Intervallo di date
Tu sei qui: Storia e StorieQuel gelido Natale tra gli esclusi non rassegnati di Poggioreale
Inserito da Andrea Manzi (redazionelda), domenica 13 dicembre 2015 12:30:24
Il reportage che segue, pubblicato dal quotidiano per il quale lavorava come vice direttore, fu scritto cinque anni fa da Andrea Manzi: vi si legge la desolante condizione dei detenuti "rottamati" da una società che ancora non ritiene di doversi porre il problema del loro recupero. La situazione in cinque anni non è migliorata, anzi è esplosa nella sua più preoccupante gravità... Riproponiamo quindi quel testo - una cronaca densa e partecipata del pranzo di Natale organizzato a Poggioreale - nell'auspicio che, in questi giorni pre-festivi, di facili e ostentate solidarietà, ci si dedichi concretamente alla condizione orribile di quanti vivono senza libertà, senza dignità e soprattutto senza più speranza.
Quel gelido Natale tra gli esclusi non rassegnati di Poggioreale
di Andrea Manzi

In fondo alla chiesa adibita a refettorio, entrando a sinistra, c'è un Gesù nudo che sanguina sulla croce. Ai suoi piedi un foglio bianco, leggermente ondulato come una calda, comoda sciarpa. Una mano incerta vi ha scritto sopra, con un pennarello rosso, un versetto del Vangelo di Giovanni (1, 14): "Pose la sua tenda tra gli uomini". Ai lati, sotto il muro, accatastati uno sull'altro, i banchi della messa che hanno ceduto lo spazio ai tavoli con la tovaglia di carta increspata anch'essa color rosso sangue, superfici precarie ricavate probabilmente dall'imperfetto congiungimento di malfermi tavolinetti quadrati da bar di periferia. Sono addossati con ordine e lasciano libero un passaggio centrale ampio, una sorta di navata nella quale Antonio Mattone, portavoce della Comunità di Sant'Egidio, si muove da padrone di casa, dirigendo ardue operazioni di approvvigionamento. Mattone "viene ogni giorno" puntualizza Pippo, che è arrivato a fine luglio per un omicidio che non gli dà pace e per il quale si proclama innocente. "Non proprio ogni giorno" precisa Mattone, rivolto al ragazzo con un sorriso aperto e complice. Se dai le spalle all'altare, che è coperto da un telo, questa variopinta assemblea del pranzo di Natale è smembrata in due ali simmetriche. Sembra un esercito disposto in fila per due che staziona per rifocillarsi, prima di avanzare mestamente nel nulla. Ad ogni tavolo siedono dieci persone, presenze discrete e variopinte. Tutti i cento commensali indossano il maglione buono - dominano il giallo e il rosso - o la tuta azzurra lavata e stirata per la grande occasione. Età media, trent'anni. Capelli pettinati, gli extracomunitari prediligono la fila centrale col tocco maudit di brillantina ordinatrice. Perfetto microcosmo di integrazione razziale, questo carcere: una lezione per gli incolti leghismi razzisti di fuori.
Gli abitanti di questa severa casa sono ragazzi dapprincipio un po' smarriti sotto le telecamere Rai e davanti agli occhi indiscreti della pattuglia di cronisti sensibili al loro richiamo. Nessuno di loro accusa, però, la sindrome dell'assedio. Mangiano cannelloni, polpettone per secondo e, infinita generosità della provvidenza, c'è anche il contorno di patate con cipolle condite da una salsetta soave di olio, prezzemolo e aceto. Cesti di agrumi e vaschette di fichi secchi consentono di chiudere il pranzo dell'anno con la bocca paga e inzuccherata. A richiesta, arriva un dito di vino rosso che solerti ragazze versano con parsimoniosa cura negli instabili bicchieri di carta. Cose dell'altro mondo, per chi in sette metri per tre, a Poggioreale, il carcere più grande d'Europa, convive perlomeno con altri dieci compagni di pena ed ha ricavato, in ventuno metri quadrati, lo spazio per tribali servizi igienici comunitari, cucina e mensa da campo. Miracolo dell'architettura coatta.
Appaiono contenti i detenuti, ma sulla gioia del momento è disteso leggero come un velo ed evidente come un calco un soffio d'angoscia, che spalma sulle facce ghigni e sorrisi artefatti. I rari momenti belli - spiegano - aprono in carcere il sipario sull'angoscia del dopo, sulla solitudine che a Natale è una lama affilata girata nel cuore, una lama che dilania la carne e non uccide. E' come se ogni sorriso contenesse un pianto e comunicasse il perfetto contrario della gioia, una sorta di sindrome da sabato del villaggio, un grumo di pessimismo cosmico.
All'inizio la platea è come quella di un irreale teatro artico. Anche noi visitatori abitiamo una città fantasma, viene in mente Italo Calvino e la rarefazione della realtà urbana. Le pareti laterali sembrano foderate di ghiaccio, nonostante imperioso, entrando, probabilmente al fianco di quel che in giorni normali sarà l'altare, ti si para in faccia questo Cristo con il capo reclinato sulla spalla e cinto dalla corona di spine. Un povero Cristo messo lì come segno di possibile liquefazione del gelo. Il sangue che gli sgorga è un flusso rosso che tutti, qui dentro, immaginano - chissà perché - caldo come il brodo ristoratore quando arriva l'inverno rigido. In quel sangue si disciolgono antichi grumi, ed infatti il Cristo della statua è più vivo di quanto s'immagini. Per i ragazzi è in perenne ascolto, tant'è che vi si aggrappano sicuri di essere abbracciati e accolti. Cristo per loro è di carne e ossa. Prima di sedere, quasi tutti, vanno a baciargli il ginocchio spellato e segue, immancabile, da parte di ciascuno, un segno della croce rispettoso e con l'inchino.
Non si sentono, tuttavia, pesciolini nell'acquario, questi ragazzoni che il carcere ha anestetizzato senza concedere loro una misera chance. Non avvertono di essere sotto i riflettori di alcuna curiosità morbosa e del compatimento. Ed infatti non lo sono, li circonda un profondo rispetto. Essi lo sanno e, chi prima chi dopo, si sciolgono con noi "forestieri" in una loquacità generosa. Capovolgono il rapporto ed osservano con feroce incredulità quel segmento di mondo esterno piombato nell'inferno del loro carcere. Il segmento ospite saremmo noi, persone apparentemente normali. I detenuti sembrano dirci: "Ma come puoi non farne del mio dramma l'impegno della tua vita?", "Ma non lo vedi che ci hanno condannato non alla reclusione ma all'inferno?". E sono bravissimi a portare l'interlocutore nel loro mondo di ricordi e di innocenze assolute e, forse, in qualche caso, autentiche.
Pippo dice di non aver sparato volontariamente al suo amico più caro. Il colpo partì nel chiudere l'arma, e il botto coprì lo scatto. "La mia vita è finita in quel momento, anche se non ho colpe e infatti non mi accusa nessuno: è un omicidio colposo, ma mi hanno contestato quello volontario. Un prete sta promuovendo una colletta per l'avvocato, perché sa che sono innocente. Se non hai soldi qui dentro puoi crepare": gli occhi rapaci di questo venticinquenne vestito di nero come un corvo malinconico si portano dentro una ferita profonda. "Tu sei il bimbo nella mangiatoia" gli direbbe Sylvia Plath per rassicurarlo, temendo di lui e di suoi simili il cosiddetto suicidio logico, quello del Kirillov dei Démoni per intenderci. Pippo infatti non è spaventato dal processo e dall'ipotesi di una dura condanna. Teme piuttosto lo sgomento di quest'inferno quotidiano nascosto dietro mura spesse e umide, dove anche quel Dio che i ragazzi baciano in croce sembra agonizzare e perdersi nell'incoscienza. Sono pensieri catastrofici i suoi, che hanno qualche affinità illustre. Il poeta John Donne sostenne che la volontaria morte di Cristo (volontaria, perché avrebbe, secondo lui, potuto sottrarvisi) alimenta l'ipotesi di un Dio suicida o, comunque, alle corde. "Un Dio che crea il mondo - scrisse Borges, rileggendo Donne - per erigervi il proprio patibolo". Pippo non conosce il quadro eziologico delle angosce dei poeti, ma sa tutto sull'impoeticità della sua condizione bestiale. "Stiamo male, le celle sono gelide ma noi siamo costretti a vivere con le finestre aperte, perché in tre metri per sette ci stiamo in tanti: qui dormiamo, c'è il cesso, cuciniamo, mangiamo e non c'è acqua calda. D'estate il caldo ci ammazza, viviamo in vere e proprie saune, gli svenimenti sono frequenti. Fuori dalla cella stiamo solo un'ora al giorno, che spesso si riduce a 40-45 minuti. Le altre 23 ore della giornata le trascorriamo lì dentro, sotto chiave". Una favola, dunque, quella che si racconta all'esterno, secondo la quale la porta di ferro resta aperta per molto tempo nella giornata. "E' chiusa per tutto il giorno, non esiste socializzazione, i colloqui settimanali con i familiari spesso avvengono anche al dodicesimo giorno. Non c'è il lavoro, per un colloquio con lo psicologo fai la domanda e poi aspetti, può passare anche un mese, spesso la risposta non arriva proprio. Alla famiglia puoi telefonare una sola volta al mese, per qualche minuto. E a volte non te lo consentono. Non c'è altro, questa è la nostra vita". A Poggioreale, oltre alla ripugnanza estetica del luogo, ti si parano davanti agli occhi facce profonde come gli abissi. Facce che parlano di assurdità, di violenza che impregna anche l'aria che si respira. Facce d'abisso, dove abisso sta per incolmabile voragine che separa, direbbe Camus, la certezza della propria esistenza e il contenuto che si riesce a dare ad essa.
Amil è tunisino, anch'egli si dichiara innocente e non per la prassi consolidata nelle carceri di chiamarsi fuori negando anche l'evidenza, quanto piuttosto per un racconto logico stringente. Egli confessa al cronista anche colpe che i magistrati non gli hanno contestato, ma la droga nell'auto che lo ha portato a Poggioreale giura che gli investigatori ce l'hanno messa per incastrarlo, "per fottermi" dice. Lo avranno ritenuto - prima di qualsiasi giudizio - indegno della sua libertà. A volte, purtroppo, la legge utilizza metodi criminali. Amil parla come se fosse libero. Avverte l'ingiustizia della sanzione e si è come auto-assolto e mentalmente liberato, nonostante i fatti e i luoghi che lo circondano si incarichino di contraddire tale sua libertà. "Difficile dovergli credere, ma è quasi assurdo non farlo" sussurra la collega Donatella Trotta, presidente dell'Ucsi, colpita dal racconto così articolato e verosimile del ragazzo. Ma le ragioni di Amil non contano in questa società, dove la giustizia troppo spesso condanna all'infecondità delle vite oltre che alla pena del carcere. E' assurdo tutto ciò, ma tristemente vero a Poggioreale. Non per nulla siamo nell'istituto più bassamente celebrato d'Europa, del quale ciclicamente si chiede la chiusura come unica forma di perequazione tra le condizioni di vita dei detenuti italiani. Costruito nel 1908, suddiviso in 12 padiglioni con i nomi delle più belle città d'Italia, ha passeggi che sono quadrati di cemento e non conosce spazi per esperienze comuni. "Il modello detentivo cui l'istituto fa riferimento è quello di fine ‘800: cameroni, letti a castello, reparti aperti su tre piani, le celle lungo un ballatoio aperto al centro, una rete che si sostituisce al soffitto", raccontano le macabre guide su Internet. Tanti i casi di suicidio, "autodistruzione senza rimpianti" chiosano gli psichiatri. Tradotto in parole povere, fuga liberatoria da un inferno di dodici gironi, dove sono stipate fino a 2.800 anime in pena (2.500 nel giorno di Natale) contro le 1400 contenibili.
Don Franco Esposito, dopo il pranzo, sale sul palchetto d'occasione e racconta l'abiezione metropolitana di Poggioreale, che si traduce in una impunita riduzione in schiavitù di migliaia di persone. È un idolo questo cappellano. "Solo lui ci vuole bene", sentenzia Pippo. I detenuti si spellano le mani per applaudire, quando il sacerdote tuona contro una vita che diventa attesa vuota. "Non ci sono spazi, manca il lavoro, le celle chiuse per tutto il giorno. Così si vogliono recuperare le persone?": nelle parole del sacerdote compaiono le chiavi per dare senso ai tanti suicidi avvenuti qui dentro. Capisci perché ammazzarsi tra queste mura non risponda ad una necessità causale, quasi che "l'epilogo fosse già scritto nelle officine del destino". No, la causa vera è in questa vita "di noi detenuti": don Franco vive una piena identificazione con i suoi ragazzi, dice "noi", ma probabilmente non si rende nemmeno conto del plurale maiestatis.
Le denunce degli ultimi mesi sulla violenza di questo carcere, resa ancora più intollerabile per le cure negate ai reclusi (gli avvocati penalisti hanno denunciato anche "negligenze dei magistrati", a proposito si sta indagando su questo?), sembrano fondate. I detenuti raccontano di malati cronici di epatite non curati, abbandonati alla loro penosa sorte e conviventi con soggetti sani superesposti, pertanto, al rischio del contagio. Raccontano di corpi che si trasformano nel male e decadono, abbrutiti, verso il più tragico epilogo. Tuttavia, nonostante questa vita sprofondata nell'abisso, dentro Poggioreale ci si attacca ad un'esile speranza. Don Franco la dispensa come dono antistress. Quando il direttore del carcere Cosimo Giordano, dal palco, promette imminenti miglioramenti, arrivano applausi anche per lui. E' un uomo sorridente, arrivato qui dentro da un anno e mezzo. Si dà tanto da fare. Annuncia un finanziamento di 120mila euro della Regione. Con quei soldi si costruirà un campetto per potersi muoversi un po'. Nel mare magnum dei finanziamenti disposti dall'impero bassoliniano, 120mila euro per i carcerati sono un insulto, ma qui dove il dolore opprime appaiono come uno smisurato slancio di generosità.
La festa volge al termine, arrivano i dolci natalizi e ci si prepara per la cantata dei pastori. Guadagnano il palco Gianni Lamagna, Lello Giulivo e un affiatato gruppo folk. Nella loro voce, vive la più bella Napoli delle tradizioni forti e della ritualità popolare colta. I detenuti applaudono, non è vero che i loro unici idoli sono i neomelodici e i penosi epigoni dei cantanti di giacca. Accompagnano gli artisti con carambole ritmiche, rivoltano i ritornelli come frittelle e adombrano compiaciuti qualche viscerale doppio senso. A tratti, tra un brano e l'altro, si lanciano in filastrocche ammaccate.
Sono passate due ore, poco più. Fuori le guardie già organizzano le traduzioni nei padiglioni. I detenuti sanno che la festa è finita. Qualcuno si commuove. Vincenzo spera nel tempo che passi in fretta ("Il mio fine pena è 2014, ma in cella stanno tutti peggio di me"), altri chiedono se la Comunità di Sant'Egidio non pensi, per caso, di ripetere più spesso un pranzo-spettacolo. Qui basta una festa per fare Natale. E c'è bisogno di farlo nascere più spesso il Bambino che, per altri 364 giorni all'anno, non nasce e non muore. La voglia di comunicare vissuti, a Poggioreale, è forte e si manifesta anche nel venerdì santo. I detenuti, nelle 14 stazioni, fanno la parte di Cristo e raccontano le loro storie liberandosi - con parole stizzite e spinose - di sofferti vissuti. "Difficile resistere, stai male, è un'esperienza troppo forte" racconta Donatella Trotta. Sono fiori popolari che spuntano in un deserto identificato con il male.
Salutiamo e, con il collega Andrea Acampa, ci avviamo all'uscita. Assistiamo alla struggente separazione tra un padre e un figlio, incontratisi al pranzo: sono due incensurati finiti dentro per una storia contorta. Il direttore ha consentito che mangiassero allo stesso tavolo. Un incontro tenerissimo, il loro.
Lamagna e Giulivo sono agli ultimi brani.
Alle spalle lo scatto gelido dei cancelli che si chiudono, sbattendo.
Tra pochi minuti, il tempo rimetterà i calzari di piombo. E a Poggioreale farà buio nel cuore.
Nella foto un momento del pranzo di Natale del 2010 a Poggioreale con Andrea Manzi tra i detenuti

Se sei arrivato fino a qui, significa che apprezzi il nostro impegno nel fornire notizie libere e accessibili a tutti.
Per garantire un ambiente sicuro per i nostri lettori, abbiamo rimosso tutta la pubblicità invasiva, i cookie e i tracciamenti di terze parti.
Tuttavia, per continuare a offrirti un'informazione di qualità, il tuo aiuto è fondamentale. Anche un piccolo contributo può fare la differenza.
Sostieni Il Vescovado!
Scegli il tuo contributo con ![]()
Per rimanere costantemente aggiornati con le notizie del Vescovado, in tempo reale sul tuo smartphone, scarica la App!
|
Per dispositivi Apple |
Per dispositivi Android |
 |
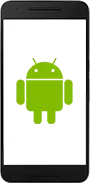 |

rank: 106936108