Intervallo di date
Tu sei qui: Storia e StorieIl Venerdì Santo dei nostri nonni: la pia pratica delle tre ore di agonia
Inserito da (redazionelda), venerdì 2 aprile 2021 10:51:23
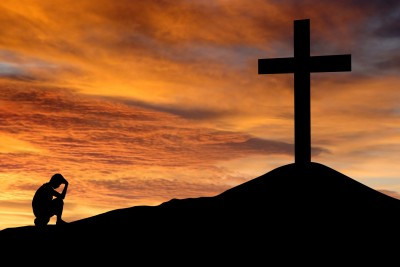
di Donato Sarno
Un tempo la Quaresima era un periodo di penitenza e mortificazione particolarmente sentito, in cui venivano generalmente e scrupolosamente osservate le norme della Chiesa che imponevano il digiuno e l'astinenza dalle carni in preparazione alla Pasqua. Il Venerdì Santo, giorno di commemorazione della morte di Gesù Cristo, regnava ovunque un clima di grande silenzio e di profonda mestizia, interrotto solo dai canti penitenziali dei battenti; dopo l'avvento della radio e della televisione, anche queste ultime, in segno di lutto, si astenevano dal trasmettere musiche o spettacoli frivoli.
Una funzione assai partecipata - che i più anziani tuttora ben ricordano - si svolgeva nelle varie chiese dalle ore 12.00 alle ore 15.00 del Venerdì Santo ed era detta "le tre ore di agonia". Si trattava di una pia pratica, sorta in America Latina nel XVII secolo ad opera dei Gesuiti e, in modo speciale, del Padre Alonso Mesia Bedoya (Alfonso Messia nella forma italiana), che aveva ottenuto da subito fortuna e diffusione, venendo approvata dai Pontefici ed arricchita di indulgenze. Durante queste tre ore, coincidenti volutamente con l'arco di tempo in cui Gesù stette inchiodato sulla croce, i sacerdoti salivano sul pulpito e ricordavano ai fedeli la Sua agonia, commentando le ultime sette parole pronunciate dal Redentore quando appunto si trovava in croce. Le sette parole (sette come i Sacramenti, sette come i doni dello Spirito Santo e sette come le virtù), considerate quale testamento spirituale del Cristo, sono le seguenti, tutte tratte dai Vangeli e cariche di altissimo significato:
Le prediche si tenevano di regola innanzi ad un grande Crocifisso issato sull'altare maggiore, nell'ambito di una efficace scenografia riproducente il Calvario, ed avevano accenti intensi, con forti gestualità e con toni di voce che ora si innalzavano e ora si abbassavano. I sacerdoti infatti utilizzavano tutta l'abilità oratoria per cui erano stati formati (allora l'eloquenza sacra era una vera e propria arte), giungendo talvolta anche a flagellarsi sul pulpito; si ricordavano con parole vibranti l'atrocità dei supplizi patiti dal Cristo e la bruttezza del peccato, che era stata la causa della sua dolorosa Passione, e tutti i presenti restavano profondamente colpiti, commossi e contriti. Le prediche erano intervallate sovente da componimenti musicali, per ancor più drammatizzare e far rivivere le sofferenze e gli strazi di Gesù.
La pia pratica, in effetti, ben si inseriva, ulteriormente valorizzandola, nell'atmosfera penitenziale della Settimana Santa, quando nelle chiese le croci degli altari e le immagine erano coperte in segno di lutto con veli violacei, e nel clima di dolore proprio del Venerdì Santo, che raggiungeva poi il suo culmine la sera, con le suggestive processioni di Gesù morto.
Dopo le modifiche introdotte, a partire dal 1956, nei riti della Settimana Santa, la pratica delle tre ore d'agonia, pur non essendo mai stata eliminata o vietata, finì purtroppo col cadere gradualmente in disuso, tant'è che ora sopravvive solo in poche parrocchie.
La pratica ha comunque avuto storicamente un merito enorme: quello cioè di aver formato tante generazioni di persone, chiamandole a contemplare - come diceva il Padre Messia - "con somma attenzione e riverenza i tormenti, le ambasce e le angustie mortali che nello spazio di queste tre ore d'agonia patì sulla croce il nostro Redentore (...) tanto crudeli e orrende (...) per offrire a pro nostro, con amore sviscerato, il Suo sangue e la Sua vita in sacrifizio all'Eterno Suo Padre".
Ricordare dunque oggi la funzione delle tre ore di agonia serve sia a fare memoria delle esperienze religiose dei nostri anziani e di quanti, prima di essi, ci hanno preceduto sia, soprattutto, a far meglio comprendere il significato profondo del Venerdì Santo, che, in un contesto sempre più secolarizzato e privo di valori, rischia di essere percepito e vissuto, specie dalle nuove generazioni, nella più totale indifferenza e come un giorno qualsiasi
Se sei arrivato fino a qui, significa che apprezzi il nostro impegno nel fornire notizie libere e accessibili a tutti.
Per garantire un ambiente sicuro per i nostri lettori, abbiamo rimosso tutta la pubblicità invasiva, i cookie e i tracciamenti di terze parti.
Tuttavia, per continuare a offrirti un'informazione di qualità, il tuo aiuto è fondamentale. Anche un piccolo contributo può fare la differenza.
Sostieni Il Vescovado!
Scegli il tuo contributo con ![]()
Per rimanere costantemente aggiornati con le notizie del Vescovado, in tempo reale sul tuo smartphone, scarica la App!
|
Per dispositivi Apple |
Per dispositivi Android |
 |
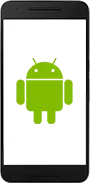 |

rank: 105746106